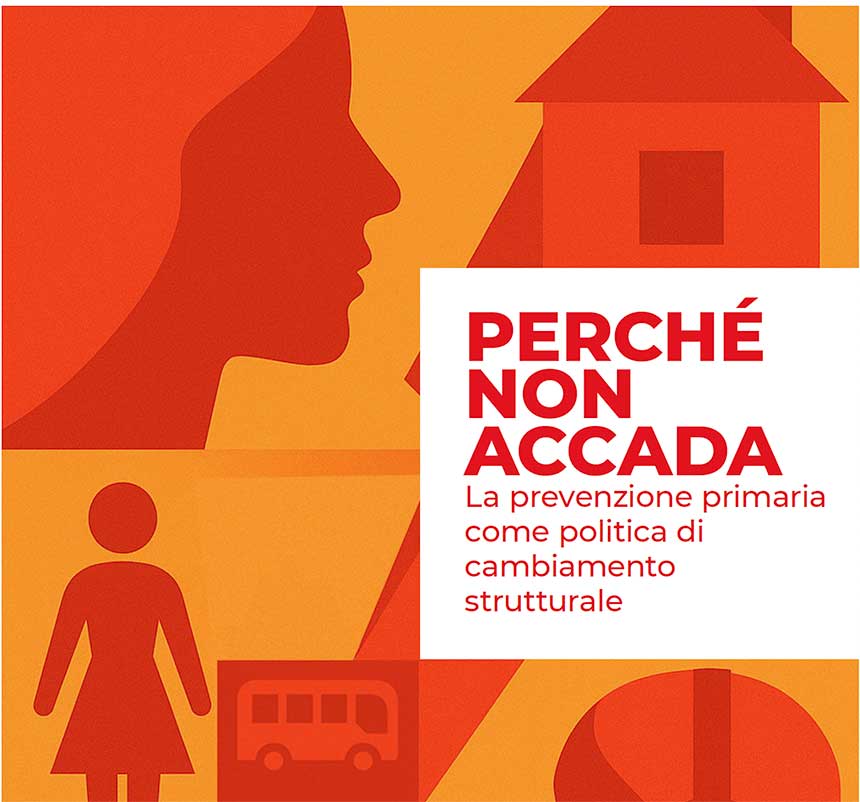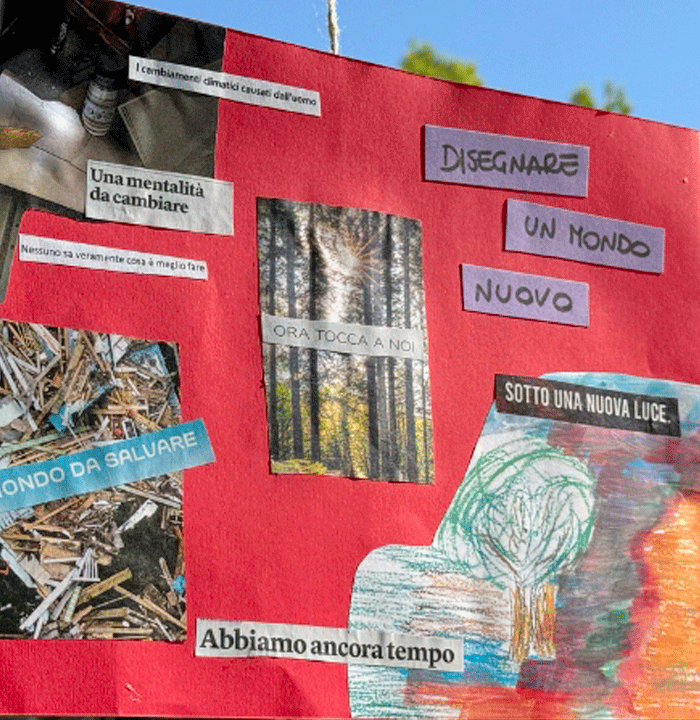I numeri di un fenomeno in parte invisibile
Per il terzo anno consecutivo, come ActionAid abbiamo pubblicato un rapporto sui numeri relativi alla povertà alimentare in Italia.
L’analisi si basa sui principali dati disponibili nel database ISTAT, a partire dall’indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC), dalla FIES (la scala basata sull’esperienza dell’insicurezza alimentare) e dall’indagine sui consumi.
Deprivazione alimentare: i dati del 2023
Nel 2023, circa l’11,8% della popolazione sopra i 16 anni ha sperimentato almeno una forma di deprivazione alimentare, secondo l’indice di Deprivazione Alimentare Materiale o Sociale (DAMS). Si tratta di circa sei milioni di persone, in aumento rispetto all’anno precedente. Tra queste, tre milioni vivono difficoltà di tipo materiale – legate all’impossibilità economica di accedere a un’alimentazione adeguata – mentre quasi due milioni si trovano in una condizione di esclusione sociale legata al cibo, ad esempio per l’impossibilità di vivere il pasto come momento di socialità e condivisione con altri. Oltre un milione di persone sperimenta entrambe le forme.
Povertà alimentare anche tra chi non è “ufficialmente” povero
Nonostante il numero complessivo di persone formalmente a rischio di povertà sia diminuito (da 9,7 a 9,2 milioni), è aumentata la quota di chi, all’interno di questa fascia, vive anche una condizione di povertà alimentare. Ma il dato forse più significativo riguarda chi non è classificato come povero secondo le soglie ufficiali: 3,6 milioni di persone vivono comunque una condizione di deprivazione alimentare, spesso invisibile agli strumenti di intervento pubblico.
Secondo i dati FIES, che misurano l’insicurezza alimentare sulla base delle esperienze vissute dalle persone in relazione all’accesso al cibo, nel 2023 circa il 3,6% della popolazione italiana – pari a oltre 1,8 milioni di individui – ha vissuto una condizione di insicurezza alimentare moderata o grave.
L’insicurezza moderata si riferisce a situazioni in cui si è costretti a ridurre la qualità o la varietà del cibo, diminuire le quantità o saltare i pasti; quella grave implica invece l’assenza completa di cibo per uno o più giorni.
I risultati appaiono più contenuti rispetto ai dati del DAMS perché si tratta di uno strumento pensato per essere applicato in contesti molto diversi, in particolare nei Paesi dove l’insicurezza alimentare assume forme più gravi e diffuse.
Pur con questi limiti, la FIES resta uno strumento prezioso per cogliere la dimensione vissuta del fenomeno, a partire dalle esperienze quotidiane delle persone.

Non solo mancanza di denaro: il cibo come riflesso delle diseguaglianze
Questi dati confermano che la povertà alimentare non coincide semplicemente con la mancanza di risorse economiche, ma è legata a un intreccio di disuguaglianze che colpiscono la vita quotidiana: precarietà lavorativa, aumento degli affitti, rincari dei beni essenziali, figli a carico, disuguaglianze di genere, background migratorio.
Il cibo, in questo scenario, diventa spesso la prima voce su cui si risparmia, generando forme di esclusione silenziosa anche tra chi ha redditi medio-bassi.
È qui che la povertà alimentare assume forme meno visibili, fatte non necessariamente di scarsità assoluta di cibo, ma di rinunce silenziose e quotidiane. Si rinuncia alla varietà e alla qualità, alla possibilità di scegliere, di condividere un pasto, di vivere l’alimentazione come esperienza di piacere, cura e relazione.
È una condizione che investe profondamente il rapporto quotidiano con il cibo, influenzando le pratiche, le emozioni e i legami sociali. Non è solo deprivazione materiale, ma anche psicologica e relazionale, perché il cibo non è semplicemente nutrimento: è dignità.
Misurare non è solo un’operazione tecnica, ma un atto politico. Le scelte su cosa osservare, come definirlo e come rappresentarlo influenzano la comprensione del fenomeno, la lettura delle sue cause e, di conseguenza, le risposte che vengono messe in campo.
È quanto abbiamo cercato di mostrare anche nel rapporto Fragili equilibri, che esplora la povertà alimentare a partire da disuguaglianze, vissuti e dimensioni invisibili.
L’assenza di una politica strutturale di contrasto
Di fronte a questi dati, le risposte messe in campo dalle istituzioni e dalla società civile restano ancora frammentarie. L’Italia non dispone oggi di una politica organica di contrasto alla povertà alimentare.
Gli interventi pubblici si concentrano sulle situazioni più estreme, senza affrontare le cause strutturali del fenomeno né raggiungere quelle fasce di popolazione che, pur vivendo condizioni di difficoltà, restano escluse dai canali tradizionali di sostegno.
È urgente ripensare approcci e strumenti, superare lo stigma che ancora accompagna l’accesso all’aiuto alimentare e costruire percorsi capaci di rispondere non solo al bisogno materiale, ma anche al benessere psicologico, alle relazioni sociali, alla solitudine.
Allo stesso tempo, servono politiche strutturali che agiscano sulle disuguaglianze territoriali, socio-economiche e di genere, che rafforzino i redditi, migliorino l’accessibilità al cibo sano.
In quest’ottica, il riconoscimento del diritto all’accesso universale alla mensa scolastica sarebbe un passo fondamentale per contrastare la povertà alimentare minorile.
Un diritto che ancora oggi non è garantito nel nostro ordinamento, ma che rappresenta una misura concreta e necessaria.